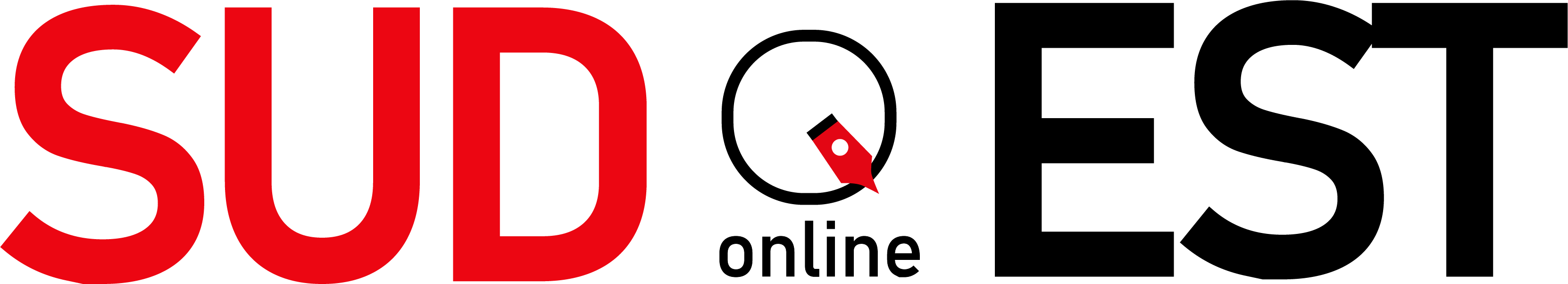La toponomastica medievale e moderna di Conversano
da DON ANGELO FANELLI, DELL’ARCHIVIO DIOCESANO DI CONVERSANO, RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
L’Archivio Diocesano di Conversano come gli antichi scriptoria medievali (ricordate “Il nome della rosa”?), che silenziosamente lavoravano nel riprodurre classici religiosi e non. Anche a Conversano (senza trascurare quello badessale) vi era certamente uno scriptorium curiale ecclesiastico, voce scritta dei vescovi. E non mancavano ovviamente le varie “lezioni”, che oggi chiameremmo refusi. Significativo al proposito è quanto riportato in una bolla del 1395, in cui il vescovo Angelo conferisce il rettorato beneficiale della chiesa di S. Croce (oggi scomparsa e vicina a S. Rocco) a Baldassarre Tarsia. L’amanuense nell’incipit annunzia salute del vescovo al figlio in Cristo iacon(o) Balthasar: gli è sfuggita la d quindi diacono, titolo peraltro confermato nelle successive pergamene, mentre il nostro storico Tarsia lo interpreta addirittura come Iohanni (p. 121). Dopo questa piccola digressione voglio dire che altrettanto silenziosamente il nostro Archivio ha lavorato fino a stampare inviti e locandine il 18 marzo come data ufficiale di presentazione del volume 29 della collana Crescamus. Ma il covid 19 aveva e ha azzerato ogni attività pubblica, e allora piuttosto che attendere una data, che resta legata sempre all’incertezza, ho ritenuto di annunciare solo attraverso questa e-mail, il volume di Antonio Fanizzi, Toponomastica medievale e moderna di Conversano con appendice documentaria su Castiglione (pp. 207), per la cui presentazione avevo rivolto l’invito al prof. Paolo Perfido, docente del Politecnico di Bari, che aveva aderito con sollecita disponibilità.
Per chi desidera prenderne conoscenza, qui di seguito due parti dell’introduzione scritta da Angelo Fanelli
1. Una toponomastica non è uno sgomitolare la viabilità di una città attraverso nomi, molti dei quali ormai sconosciuti e ignorati nella memoria collettiva, tanto più giovanile sollecitata dai nomi luccicanti del mondo canoro, sportivo e cinematografico, e in quella popolare sostituiti da toponimi, rimasti tuttora vivi nell’uso quotidiano, allusivi all’intero luogo, come Largo di Corte, già in uso nel 1474[1] e ancora nel 1599[2], ovvero per sineddoche la chiancata che oscura i personaggi nobili degli Acquaviva d’Aragona, come recita tuttora la scritta lapidea[3]. È invece uno sgomitolare il filo del tempo e del vissuto umano, civile e urbanistico di una città, ossia la vita stessa della comunità locale. Perciò è un lasciarsi trasportare e guidare lungo le correnti vitali che si sono avvicendate e coglierne tutta la laboriosità, sempre ingegnosa nella povertà, la spiritualità, le esaltazioni, le durezze e ristrettezze, i dolori, le infatuazioni, le ruberie, i saccheggi, le ideologie, le egemonie e subalternità, insomma la storia tout court.
S’intersecano e si rincorrono ora vie tortuose e strette raggomitolate nel centro storico del Casalvecchio, ora quelle più geometriche e piane del Casalnuovo: le prime, frutto di un’architettura sostanzialmente spontanea su impulso del conte Gualtieri nel 1338, le altre su ordine del conte Adriano Acquaviva d’Aragona, espressione di una pianificazione urbanistica iniziata nel 1585 quand’era sindaco Giulio Cesare Acquaviva e terminata nel 1598 quand’era sindaco Biagio Accolti, come recitano le epigrafi[4].
E raccontano nelle case palazzate le piccole corti occhieggiate nel nucleo sei-settecentesco, assenti invece nelle successive redazioni edilizie, i vichi, gli archi, i campanili che si rincorrono, il bugnato benedettino, le pietre lisce e geometriche dell’edilizia nobile, quelle irregolari celate dalla malta e calce bianca lavorata nelle calcare rurali, le chianche con i gradini fuori dell’uscio per permettere una salita altrimenti troppo ripida e giungere al primo piano e oggi gradevoli tribunette per i crocchi di ragazzi e ragazze nelle serate primaverili ed estive; i “bassi” (“iusi” di diretta derivazione latina iusum) con unica presa d’aria dall’uscio sottoposti con diversi gradini al piano stradale e ancora usati come zona giorno. Vi si legge la precisa carta d’identità sociale attraverso la variegata edilizia che rispecchia la piramide delle classi sociali.
E continuano a raccontare ancora senza sosta il tempo e la vita: la frescura estiva “là dove si perde il giorno”, che ristora le famiglie sedute all’aperto a dirsi le storie, i sogni, i problemi, i pettegolezzi, mentre i bambini “qua e là saltando / fanno lieto romore” (Leopardi); sottacciono complici gli amori sbocciati e non ancora consolidati per essere annunziati ai genitori, quelli notturni furtivi e forieri di scandalo, come quelli di don Bartolomeo Coletta[5]; risuonano degli echi festosi gregoriani dalle chiese e dalle processioni, dei pianti funebri, dei non infrequenti alterchi e grida che non sono quasi mai trascesi a fatti di sangue, a eccezione delle rare aggressioni mortali fasciste; si animano di giorno dei suoni del lavoro artigianale con martelli, seghe, scalpelli, dello stridio dei “traini” dei contadini per ritrovare quiete e silenzio di notte; ascoltano la voce gli animali che convivono nelle famiglie o nelle stalle accanto; respirano gli odori e i profumi delle cucine semplici, l’odore pungente del mosto di vino e i miasmi dei liquami non ben smaltiti o tardivamente smaltiti, fino in tragiche circostanze a essere strade di morte collettiva nelle cicliche pestilenze e particolarmente in quella di fine Seicento[6]; diventano frenetico laboratorio aperto per sgusciare le mandorle distese poi come tappeti sulla strada ad asciugare, alternandosi con i tappeti delle preziose e dolci carrube (i fichi invece e i pomodori distesi sulle sporte per una maggiore tutela igienica si sporgono dall’alto dei parapetti dei terrazzini); ospitano sul bordo le filiformi viti che s’inerpicano lungo il muro delle case per aprirsi sul terrazzo a ombroso e fecondo pergolato; si prestano ad accogliere le tinozze d’acqua per sciacquare i pomodori da spremere nei passapomodori e non rifiutano i fuochi sotto i pentoloni per la loro cottura ovvero per ottenere con la cenere la liscivia e con gli oli usati anche il sapone per un profumo naturale del bucato; riflettono i colori dei gerani, garofani, fiori di campo sugli stretti balconi, delle collane di agli, cipolle, peperoncini, appesi ai muri e dei prodotti dell’orto seccati al sole sulle sporte come provvigione per l’inverno; sono insomma le arterie pulsanti della vita familiare e sociale della città, come quelle del corpo umano.
Sono testimoni muti e sgomenti di quel sacco spagnolo del 1503 dopo il lungo assedio subìto dalla città, in cui anche le memorie storiche redatte su pergamena andarono del tutto distrutte per fare da innesco ai cannoni, o ancora della forsennata ribellione popolare del 1886[7], in cui ancora una volta il patrimonio documentario dato alle fiamme ha impoverito la storia cittadina; testimoni ammutoliti ancora in quell’incendio della notte del 10-11 luglio del 1911 in cui il tempio maggiore, cattedra vescovile, fiammeggiava totalmente, riversando su di esse fumo ed estinzione della storia cultuale; testimoni impotenti delle vocianti parate fasciste inneggianti alla guerra esaltata dal Dio-patria-famiglia, e non alla vera religione della libertà.
Tutto il tessuto urbanistico poi è punteggiato dalle chiese a cominciare dalla cattedrale sull’apice del colle insieme al castello, ambedue espressioni non solo urbanistiche del potere egemone che è sopra il popolo, ma anche della concezione medievale dei due poteri, quello spirituale e quello temporale; seguono tante piccole chiese, fondate dalla devozione se non dall’appariscente prestigio di una nobiltà o borghesia e legate a redditi beneficiali che si esplicavano negli atti cultuali strettamente codificati; di esse alcune sono andate totalmente deperditae, altre sono state inglobate nell’edilizia privata dopo essere state dichiarate profane dall’autorità vescovile per il degrado dovuto alla noncuranza dei successori degli antichi fondatori e/o per la penuria dei redditi beneficiali, erosi dall’inflazione, chiese di cui a stento si riconosce ancora qualche vestigio architettonico.
2. Le strade dunque non sono semplici parole amorfe, ma parlano, evocano, attirano, respingono, complici di amori, di odio, di amicizie, di sangue, di generosità, di accaniti quanto immotivati rifiuti. Le nostre non sono fatte di asettici numeri, ma diventano umane; c’è una bella differenza, per citare un solo esempio, tra la Fifth Avenue di New York che ti porta alla cattolica St. Patrick church o all’anglicana St. Thomas church, e l’antica Basin street di New Orleans, accattivante pur nella sua dubbia moralità e prodiga di sogni dopo i tanti giorni di lavori estenuanti, malpagati e repressivi, come oggi per i nostri fratelli africani nelle nostre campagne di pomodori o di agrumi, al punto da sublimarsi nella musica e divenire la struggente Basin street blues.
La strada non è solo materialità, ma si eleva a metafora. Così nella favola di Prodico del sofista Cleo, riportata da Senofonte[8] e tradotta anche da Leopardi, nella quale Ercole attraverso la voce di due donne, la prima avvenente e pudica e la seconda carnale e appariscente, si trova interpellato dinanzi al bivio delle due vie (odoì): quella che porta alla virtù (aretè) e alla sapienza e quella che porta al vizio (kakìa) e al godimento; la prima è via da percorrere con fatica e sacrificio, la seconda piacevole e agevole[9]. Ed Ercole è l’uomo di ogni tempo sempre al bivio tra bene e male, tra umanità e disumanità, giustizia e ingiustizia, pace e odio, democrazia e dittatura, accoglienza e respingimento.
La strada è la metafora felliniana di un uomo, Zampanò, violento, rozzo, forzuto e muscolare, anaffettivo e incapace di quei sentimenti umani che solo alla fine riuscirà a recuperare nel pianto, e la vita di una donna, dolce, mite, sognante, remissiva che subisce senza ribellione le angherie sulla sua dignità di donna, fino a quando, abbandonata, non scompare e sarà la morte ad averla ghermita.
La strada come metafora filosofica dell’uomo, che dai primordi delle caverne, con la scoperta del fuoco che gli permetteva di allungare la luce del giorno, inventando e articolando il linguaggio e impregnandolo del pensiero, ha intrapreso a percorrere la via della sua interiorità alla ricerca dell’archè: dapprima lo ha identificato negli elementi naturali e poi, sviluppando la ricerca nella profondità del suo pensiero, è giunto alla scoperta del Logos, e quindi dell’uomo stesso quale logos seminale (spermaticòs), come affermavano i primi filosofi cristiani, per proseguire poi nella conoscenza fino all’affermazione dello Spirito, dialetticamente interpretato. Nella strada della sua libertà l’uomo si ritrova dinanzi al formicolante incrocio delle sue pulsioni naturali e istintive che impazzano tramutandosi perfino in farneticanti ideologie, dinanzi alle quali è necessaria almeno un’indispensabile epochè perché si riconduca alla ragione; è questa che lo rende “divino” e lo guida alla salvezza del suo essere, sconfiggendo la tenebrosità e la follia di quel sonno della ragione che lo porta invece alla deriva e al suo naufragio. Occorre sempre percorrere la via di Damasco.
La strada è ancora metafora, e non certo ultima, della parola, via che veicola il pensiero dell’uomo, altrimenti inattingibile dagli altri, e realizza l’azione, comunica i sentimenti, si eleva alla poesia e all’arte nelle sue varie forme; e la via regale (basilichè odòs) per il giudeo Filone di Alessandria è la parola divina per eccellenza.
E infine, per non proseguire a sviluppare ulteriormente altre metafore, la via s’identifica perfino con l’uomo stesso; è Gesù che si autoproclama: Io sono la via (egò eimì e odòs), che quindi nelle due successive autoproclamazioni conduce alla verità (egò eimì e alétheia) e alla vita (egò eimì e zoè)[10], e di conseguenza alla salvezza (soterìa).