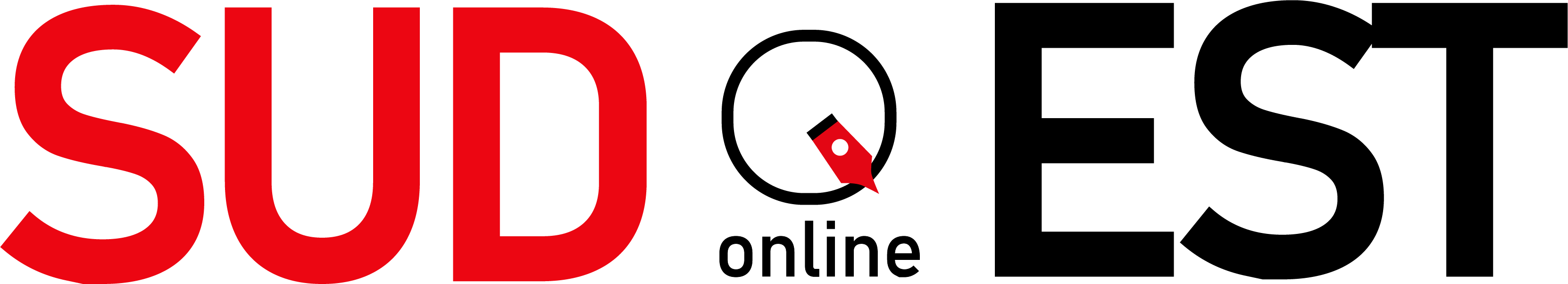La morte dell’Io: il Santo Graal e il fuoco sacro della poesia
La morte dell’Io: il Santo Graal e il fuoco sacro della poesia
Saggio breve di Fabio Angiulli
Introduzione
 Sento spirare e perdersi un vento sapienziale dai libri della mia biblioteca, al lume di una notte di scrittura davanti ad un foglio elettronico, mentre il buio fuori è rotto da lampi autunnali che annunciano temporale tra la notte dei neon del paese.
Sento spirare e perdersi un vento sapienziale dai libri della mia biblioteca, al lume di una notte di scrittura davanti ad un foglio elettronico, mentre il buio fuori è rotto da lampi autunnali che annunciano temporale tra la notte dei neon del paese.
Ferisco il silenzio notturno con i battiti delle dita sulla tastiera e m’illudo di esserci davvero.
Di esistere. Un po’ come Cartesio immerso nella storia del suo tempo Seicentesco di una Francia in cui dominava il pensiero come fonte dell’esistere: cogito ergo sum, sentenziava il filosofo René Descartes mentre anche il dubbio gli dava la certezza della sua esistenza e in quanto sostanza pensante anche se pensava che tutto fosse falso, lui che lo pensava fosse qualcosa, necessariamente.
A me pare un egocentrismo tormentato.
Un mare che lo assale in un male di res cogitans.
Credo che i pensatori abbiano smesso di pensare o meglio di pensare come Cartesio e noi in questo Viaggio notturno ci addentreremo nella notte del non pensare, spegnendo tutti i lumini artificiali Seicenteschi che fanno eco fino al Terzo Millennio.
Cercheremo in questo viaggio la nostra verità, che rovescia quella cartesiana.
Non pensare a niente sentenziava Carmelo Bene, e con questo l’approdo del nostro cammino alla fonte dell’Essere e la morte del soggetto.
L’annientamento del concetto di soggetto o morte dell’io dialettico sono considerati dalla notte dei tempi da scrittori e pensatori, il vero Santo Graal; un viaggio o un’odissea in cui l’io naufraga dolcemente, parafrasando il poeta di Recanati ed emerge il sé superiore, poiché l’annientamento di cui parla Arthur Rimbaud nella lettera del Veggente, idealizza una figura di poeta, a cui egli stesso ambisce attraverso
l’annientamento di tutti i sensi; il disfarsi e il perire del concetto di soggetto, per dirla con Carmelo Bene, in cui nel suoi teatro vedeva la rappresentazione di un sacro nulla; una sacralità del nulla come fonte stessa dell’Essere.
Allora ci poniamo il dilemma amletico: Essere o non Essere?, questo è il problema… Ma l’ostacolo sarebbe sognare…
Quale sarebbe il sogno?, forse le nostre stesse esistenze, per le millenarie filosofie esoteriche non sono considerate forse un sogno?
Ma adesso cercheremo nuove chiavi di volta per comprendere, e sciogliere
arcani tra i meandri della Storia della Letteratura, cercando di comprendere o per meglio dire essere compresi in questo dolce naufragio.
E salvarci dalla burrasca del tormentoso io, per sfondare gli strati del pensiero, e il mare sillabico che ci imprigiona, per svolazzare via da noi stessi, verso la fonte infinita dell’Essere.
I
Parafrasi del capolavoro di Leopardi in chiave filosofica
Che il poeta di Recanati avesse letto tutti i classici del pensiero tedesco in lingua originale l’abbiamo imparato sui banchi di scuola, ma la sua celeberrima poesia L’infinito nasconde riferimenti a ciò poc’anzi scritto.
Tutti immaginiamo il giovane Leopardi che mira l’orizzonte sul suo amato colle. Ma prestiamo attenzione alla siepe, che dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. Ebbene pensiamo a quell’ultimo orizzonte, la sua inconoscibilità; la mancata visione; l’impossibilità di vederlo; di toccarlo…
O per meglio dire di comprenderlo.
Il poeta di Recanati era un grande studioso e in poesia aveva l’abilità geniale di racchiudere significati filosofici da lui meticolosamente studiati.
Il capostipite dell’illuminismo tedesco Immanuel Kant divideva il fenomeno (ciò che si può comprendere) dal noumeno (la cosa in sé), ebbene, quella siepe rappresenta l’evento fenomenico, mentre il noumeno (l’ultimo orizzonte), occultato dalla siepe.
L’annegamento dell’arte del pensiero, la graduale perdita di coscienza, maturata verso dopo verso e quei verbi coniugati all’infinito, conducono ad uno smarrimento della coscienza che si perde – senza perdersi davvero – ma ritrovando la fonte dell’essere nel verso finale, in un dolce naufragio in cui si perde ogni capacità dialettica e di comprensione, poiché ormai compresi nel tutto del nulla.
II
Un passo indietro nella Storia: il Medioevo dell’esoterismo Dantesco
Dante Alighieri è vissuto in epoca medioevale, quando il mondo accadeva secondo i dettami di Dio, tra il 1265 ed è morto esiliato a Ravenna nel 1321a compimento della Divina Commedia.
Ma agganciamo la sua opera al nostro discorso.
Lo smarrimento di Dante sulla montagna del Purgatorio, in cui Virgilio l’abbandona e una luce accecante invade la navicella del suo intelletto, fa capire al lettore l’impossibilità di comprendere e Dante innanzi a ciò, invoca Apollo per continuare a scrivere ciò che ha visto o meglio ciò da cui è stato avvolto, compreso, senza la capacità di comprendere con l’intelletto.
Ma facciamo una delucidazione sul termine esoterico e la differenza con il suo contrario essoterico.
Essoterico può essere definito l’involucro, mentre esoterico è il nucleo cui arrivano soltanto pochissimi adepti; questa è la differenza sostanziale tra conoscenza esoterica ed essoterica.
Il simbolismo dantesco di cui trabocca la Divina Commedia è palese.
La visione di Beatrice – colei che porta felicità – ossia gli studi teologici, è accompagnata da diversi simboli, tra cui quattro cerchi (le quattro virtù cardinali), ecc. ma ciò che a noi interessa è il medesimo smarrimento di Dante avuto dopo dal poeta di Recanati e l’abbandono di Virgilio, per ritornare a riveder le stelle, nel viaggio psicopompo.
Riportiamo qualche verso.
La gloria di colui che tutto move
Per l’universo penetra, e risplende
In una parte più e meno altrove.
Nel ciel cher più de la sua luce prende
Fù io, e vidi cose che ridire
Né sa né può chi di là sù discende;
perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto sin profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire.
In questo primo canto del paradiso emerge l’impossibilità del dire e della comprensione poiché ormai Dante si ritrova compreso.
III
Storia e rivoluzione poetica di Art Rimbaud
Arthur Rimbaud nella sua breve esistenza terrena stravolse e aprì le strade alla poesia moderna.
Nella celebre Lettera del veggente delucida il modo straordinario di fare poesie; di farsi poeta e il capovolgimento dell’io.
Ma facciamo suonare Art Rimbaud:
Io è un altro.
pazienza per il legno
che si ritrova violino,
E al diavolo gli incoscienti,
che hanno da ridire su cose
che non sanno affatto!
Arthur Rimbaud (Charleville, 1854 – Marsiglia, 1891)
Delucidiamo i versi del Poeta – Veggente della campagna ardennése, nell’altopiano della Francia nordorientale; un poeta decadente, enigmatico, un poète maudit, che mirava a distruggere gli schemi della società borghese, il linguaggio stesso della poesia – spalancando le porte della poesia moderna o inventando la poesia, dato che nella Lettera del Veggente, indirizzata al poeta e amico Paul Demeny, il 15 maggio 1871, in cui l’enfant prodige scrive: Il poeta si fa veggente attraverso un lungo, immenso e ragionato sregolarsi di tutti i sensi.
Rimbaud definisce buona parte della poesia che lo precede, semplicemente prosa rimata; i versificatori sono autori dello sfacelo della poesia, decretando la gloria di innumerevoli generazioni di imbrattacarte. Di idioti.
Riconoscerà solo nei romantici un livello di veggenza poetica, individuando in Charles Baudelaire: il primo veggente, il Re dei Poeti, un vero Dio.
Come dirà il poeta francese Paul Verlaine, – con cui ebbe un tormentato legame artistico e sessuale – quando lo raccoglierà nell’antologia Les poètes Maudits, dichiarò: ha distrutto il canto del verso all’antica, la poesia lirica… sostituendolo con la sua cacofonica cadenza poetica…
Ci ha spazzato via tutti… Non che mi dispiaccia, cercate di capirmi…
La concezione della poesia di Rimbaud diviene conoscenza: esplorazione della propria anima, attraverso un immenso e ragionato sregolamento di tutti i sensi, reinventando un linguaggio che parla da anima ad anima.
Il poeta diviene un viaggiatore interiore ed esploratore che si addentra in spazi ignoti, mirando all’infinito e di tentare di dare forma, attraverso la parola poetica all’indicibile.
Scrivevo silenzi, notti, annotavo l’inesprimibile. Fissavo vertigini.
Guardare nell’abisso era l’obiettivo del Rimbaud, la sua volontà di andare oltre, scavalcando le mura delle parole, poste ai confini dell’Universo, della civiltà borghese divenuta produzione di arte che considerava più miserabile della miserabile borghesia, era l’inevitabile destino dell’arte come rappresentazione della società del tempo. Per definire l’arte dell’Ottocento francese Baudelaire metaforizzava la figura de Il poeta – prostituta: concezione della mercificazione dell’arte e della sua rappresentazione del potere nella società borghese.
Scrivere l’indicibile; inventare un linguaggio che disintegri la norma: il linguaggio ormai desueto della poesia e abbandonarsi al delirio ragionato e sregolato dell’immaginazione, coincide con l’abbandono della coscienza dell’io.
Rimbaud arriverà a distruggere ogni bussola orientativa fino a spostare la meta del suo viaggio verso L’Impossible, contenuto nel poema in prosa Une saison en enfer, nel secondo libro capitolo Délires II, dal titolo Alchimie du Verbe.
Questo giovane uomo, impavido, quanto incosciente e sconfinato, volle guardare l’abisso negli occhi.
Rimbaud non entrò in contatto con la filosofia di Friedrich Nietzsche. Contrariamente il filosofo di Rocken conobbe e apprezzò immensamente l’opera del giovane francese.
Amo pensare che Nietzsche abbia scritto un aforisma, all’interno dell’opera Al di là del bene e del male, mentre stesse pensando alla poesia e alla vita del bohemien nativo delle Ardenne, sfuggito dal paesino rustico e rurale di Charleville, con un tentativo distruttivo o autodistruttivo del – non più suo – io; un ospite indesiderato e impostore, che alloggiava abusivamente la sua grande Anima.
Chi combatte contro i mostri deve guardarsi dal non diventare egli stesso un mostro. E quando guardi a lungo in un abisso, anche l’abisso vorrà guardare dentro di te.
- W. Nietzsche. Al di là del ben e del male.
Ma questa è la genesi della sua concezione di poeta; rivelandosi il destino della sua dannazione.
IV
Lo stile e la rivoluzione del dire di Rimbaud
Rimbaud nasce a Charleville nel 1854 e muore a Marsiglia il 10 novembre del 1891, nota è la sua odissea a e avventura con il poeta Paul Verlaine.
Art Rimbaud sfiorò vari stili: dall’ermetismo al simbolismo fino ad approdare a un pre – nichilismo, in un tempo in cui le sue uova – e quindi il destino dell’ Occidente – non si erano ancora schiuse. Ma questo giovane uomo intuì, ciò che non fu ancora teorizzato e reso manifesto.
O perlomeno ci provò, fino a decretare la resa della poesia innanzi a un mondo ormai troppo vecchio, all’età di ventuno anni.
Rimbaud distruggerà l’ordine metaforico eliminando il come, che è sempre stato usato come paragone tra due elementi, creando l’enjambement, che semplicemente si può spiegare come un’interruzione del verso, in cui l’ultima parola sgretola e scavalca l’ordine metaforico e sintattico, del vecchiume lirico, rendendo di ermetica interpretazione l’evocazione poetica.
Un esempio di enjambement, nella poesia di Rimbaud tratto da Memoria del 1871.
Il poemetto si rivela una sorta di seduta psicanalitica, durante un’ipnosi regressiva, – quando la psicanalisi non era nemmeno in embrione. –
Riporterò versi e parafrasi del momento traumatico di un abbandono vissuto dal giovane Art, descritto nel III paragrafo del poemetto.
L’io di Rimbaud si frantuma, si sgretola e nel finale diviene elemento liquido senza principio né fine; un’identificazione, uno sgretolamento dell’io, spesso utilizzata anche da Charles Baudelaire, autore de I fiori del male.
Da Mémoire, Arthur Rimbaud, 1871.
Paragrafo III
La signora è troppo eretta nella prateria
Dove nevicano i fili del lavoro; l’ombrello
Fra le dita; calpestando l’umbella, troppo fiera per Lei;
bambini leggono nel verde fiorito
il loro libro di marocchino rosso! Ahimé, Lui,
come mille angeli bianchi che si separano per via,
si allontana oltre la montagna! Lei tutta fredda
e nera, corre! Dopo la partenza dell’uomo.
Con questi versi Rimbaud ha distrutto l’ordine metaforico con un enjambemant , un procedimento stilistico che consiste nella rotrtura della connessione unitaria metrico – sintattica di un verso si prolunga in quello successivo; in altre parole una sovrapposizione di immagini.
In questo caso il sostantivo uomo posto alla fine del componimento Mémoire fa saltare letteralmente la visioni a cui Rimbaud assiste, rendendoci spettatori del suo inconscio; della sua “seduta psicanalitica”, scritta prima della scoperta della psicanalisi, perché a parlare è l’inconscio per libere associazioni. E ciò che cui assistiamo è un trauma infantile.
Ma cerchiamo di parafrasare:
Assistiamo apparentemente a un’immagine di tramonto straziante per il giovane Art mentre un’acqua di torrente corre e diventa nera sotto le luci della sera.
Fin qui nulla di strano.
Ma Lui e Lei non sono da identificare con il sole e l’acqua semplicemente.
Il sole è simbolo fallico: l’Uomo di cui parla alla fine, e gli aggettivi, utilizzati per descrivere Lei che corre dopo la partenza dell’uomo, sono aggettivi che non si utilizzano per descrivere una persona ma l’acqua, elemento femminile.
Rimbaud dice più di quello che scrive.
Il padre di Rimbaud abbandona la famiglia, sua madre La signora troppo eretta nella prateria cerca di fermare la sua bianca vedovanza e il Rimbaud rivive il trauma dell’abbandono.
Ma dov’è Art? il suo io si è frantumato nella prima seduta psicanalitica della poesia.
Il poeta, voce inconscia narrante lo ritroviamo in altre sembianze nell’ultimo verso:
Riportiamo l’ultimo paragrafo della poesia in cui “appare Rimbaud”:
ParagrafoV
Trastullo di quest’occhio d’acqua smorte, io non poso prendere,
O canotto immobile! Oh! braccia troppo corte! Né l’uno né l’altro fiore:
né l’uno né l’altro fiore: né il giallo che m’importuna
là; né l’azzurro, amico dell’acqua color di cenere.
Ah la polvere dei salici che un’ala scuote!
Le rose dei roseti da tempo divorate!
Il mio canotto, sempre fermo; e la sua catena trascinata in fondo a quest’occhio d’acqua senza sponde, – verso quale fango?
Il Rimbaud come voleva il suo maestro Baudelaire è identificato con l’elemento liquido – senza principio né fine -, poiché io è un altro.
V
Il filo di Arianna della filosofia dall’evasione “dall’io sono”, approda a Eugenio Montale.
Partendo da Eugenio Montale, (1886 – 1981), in cui nel suo manifesto della condizione del poeta all’interno della società, Non chiederci la parola che squadri da ogni lato, che il poeta compone nel 1923, scruta con uno spietato senso critico, le certezze del secolo scorso, ormai al crepuscolo.
I versi conclusivi del componimento poetico di Montale sono: “Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”.
Parole che potrebbero sembrare la resa del poeta vate, com’è indegnamente riconosciuto e delucidato durante le lezioni di Lettere sui banchi di scuola. Effettivamente è la resa dell’io – ospite abusivo – che merita uno sfratto immediato affinché non dipani l’impostura e la menzogna, schiudendo mondi artificiali che degenerano nella poesia e arte consolatoria e finita.
La resa dell’Io sono è – al di là di ogni costruzione del divenire – il trionfale canto del poeta; il suo risveglio dal torpore ingannevole della Storia; è una filosofia che nel decretare la sua resa da Hegel a Nietzsche, è la scoperta – o riscoperta – di qualcosa che era divenuto altro da se stessa, perdendo la sua quintessenza; un ingabbiamento di ciò che non si può osare dire, dando abusivamente significato e significante; una prigione senza limiti e confini apparenti, invisibili e perfettamente arbitrari; un’alienazione perfettamente riuscita ma destinata a crollare già nelle sue fondamenta, costruite nei Secoli dell’artificio del pensiero.
Chiaramente il poeta italiano, in questi versi, compendia il pensiero del filosofo di Rocken, Friedrich Nietzsche, (1844 – 1900), la cui stella, nel firmamento filosofico, si è spenta quando fu internato in un manicomio per un crollo psicotico nel 1889.
La menzogna dell’Io, di cui parla il filosofo di Rocken è riferita all’autoaffermazione di qualcosa che non esiste, ossia: l’io…
Affermare di sapere è un altro modo di dipanare una menzogna.
Dopo il terremoto concettuale di fine Ottocento, la caduta delle certezze, concepite come eterni, cominciano a vacillare e con questo il concetto stesso di soggetto.
E qui ci viene incontro con il suo ermetismo il poeta maledetto per eccellenza; il bohemien. Infatti, Art Rimbaud scrive e rivela nella Lettera del Veggente: Io è un altro. Se l’ottone si sveglia tromba, non è affatto colpa sua. Per me è evidente: assisto allo schiudersi del mio pensiero: lo osservo, lo ascolto: lancio una nota sull’archetto: la sinfonia fa il suo sommovimento in profondità, oppure d’un balzo sulla scena.
Se i vecchi imbecilli non avessero trovato del me stesso, soltanto il significato falso non avremmo da spazzar via i milioni di scheletri che, da tempo infinito, hanno accumulato i prodotti della loro orba intelligenza, e se ne proclamano gli autori!
VI
Teoria di Jacques Lacan su Arthur Rimbaud e differenza tra l’io e l’Altro, come coinquilini incompatibili.
Quest’affermazione rimbaudiana è uno sconvolgimento linguistico in cui emerge secondo lo psicanalista e psichiatra Jacques Lacan (1901 – 1981), una sconvolgente e, forse, oserei dire: traumatica e estasiata concezione di scissione dalla “maschera dell’io”; uno sconvolgimento ontologico di fondo, ma non da intendersi come un processo di alienazione da se stesso.
Poiché se Rimbaud si fosse limitato a dire io sono un altro, sarebbe tutto più innocuo sarebbe una semplice identificazione del soggetto in un altro, al di fuori di lui ma tutto ciò non implica la dissoluzione del concetto stesso di soggetto. Poiché l’immedesimazione in un’alterità, al di fuori del proprio io non cambia lo stato dell’io stesso nella sua immedesimazione, in un soggetto o oggetto.
Ma affermare io è un altro, diventa tutto più dannatamente pericoloso ma veritiero, in quanto assume tutt’altro significato. Infatti, ciò implica che la soggettività è negata e che ogni individualità è assediata da un’Alterità che lo trascina in un abisso insondabile senza principio né fine.
L’Alterità è tutt’altro che innocua: essa perturba frammenta tormenta annienta.
Quando Art Rimbaud dice: io è un altro, prende consapevolezza della perdita di centro della sua stabilità: ferma e rassicurante e di essere uno con se stesso, e si ritrova innanzi a una presenza ingombrante dell’Altro che abita il sé.
Questa è la genesi della sua concezione di poesia.
Il decentramento del soggetto, lo smarrimento, l’abbandono dell’io, che ha perso la sua identità. La fonte della poesia rimbaudiana non è più la voce dell’io – la voce della sua soggettività ormai smarrita – , ma la voce dell’Altro che ritrova un’oggettività di cui il poeta veggente si fa capostipite – una poesia oggettuale – che si prepara attraverso lo sregolamento di tutti i sensi, all’incontro con l’altrove sconosciuto, l’ignoto, l’insondabile, l’indicibile.
Conseguentemente si approda allo sconvolgimento comunicativo e linguistico, poiché il soggetto è spodestato da un trono ontologico, grammaticale. La spersonalizzazione dell’io implica il cessare di essere soggetto per diventarne l’oggetto; l’oggetto che non coincide più con la coscienza.
Lacan spiega che l’io non è un nucleo statico, immobile o immutabile ma è un continuo eccedere: un essere fuori di sé.
Affermare che l’io è un altro è un’immagine inquietante di alienazione.
Il poeta di Charlville, per rigettare la soggettività della poesia parnassiana dell’epoca muove una critica feroce all’autoaffermazione: Io sono.
Nella sua poesia l’io diviena corpo estraneo alla coscienza, il sono, conseguentemente non può più essere fondamento del pensiero ma accorgendosi di non poter più pensare si accorge di essere non artefice – attore – del pensiero ma spettatore; ma si ritrova in una situazione di passività in cui è pensato.
Concludendo, dal punto di vista filosofico è fondamentale lo spodestamento di autore del pensiero attribuendo una paternità che non possiede.
VII
Delucidazioni psicanalitiche del concetto dell’Io.
Per quanto riguarda l’Io, il padre della psicanalisi Sigmund Freud (1856 – 1939), sentenzia: L’io non è padrone in casa propria.
È come se ci abitasse qualcun altro – una verità occultata rinchiusa in un’aviorimessa mentre, ogni attività di autoaffermazione dell’io e del sapere, quindi: dichiarare ” Io sono”, diviene un modo di innescare una valanga in cui l’Altro viene insabbiato da un’invincibile menzogna, che si rivela un trionfo del’Io, che continua come un ospite a vivere in una casa che non gli appartiene senza pagare affitto.
Ma, al lume dell’annientamento del pensiero, che rischiara il buio della notte della menzogna – perché il cogito – che nella filosofia cartesiana diviene perno sacrale dell’io: cogito ergo sum – una massima che è stata una superstar della filosofia, – ormai riconosciuta come il trionfo della sconfitta del sapere – deve spingerci ad andare Oltre.
La presa di coscienza dell’impotenza del prendere consapevolezza che “Penso dunque sono” , deve condurre all’immediato sfratto dell’io, – deponendo la volontà e trovare l’abbandono -, da una casa che abita abusivamente. Questo diviene unica via d’uscita da un egocentrismo dannoso, che conduca al decentramento e smarrimento stesso del soggetto.
Il pensiero non è più un’entità cosciente ma è in preda all’Altro che lo spodesta da padrone di casa.
Ma lo smarrimento è un ritrovamento dell’essenza.
L’io, soggettività spocchiosa, che in un delirante e smanioso egocentrismo si ritrova in un universo sconfinato, in cui pone arbitrariamente confini e forma a ciò che forma non ha.
Il fine diviene un’illusione di proclamarsi autore di una qualsiasi opera, – illuso di essere e di sapere – , riscoprendosi scisso e al di fuori di sé, ormai spodestato da un luogo che non gli appartiene: rivelando la sua – ma ormai non più sua – soggettività.
Ma l’enfant prodige di Charleville delucida e allude a questo sregolamento di tutti i sensi, seppur rinchiudendosi nel suo ermetismo, afferma nella Lettera del Veggente, indirizzata al professore Georgez Izambard del 13 maggio 1871, quando Rimbaud aveva soltanto diciassette anni : Voglio essere poeta, e lavoro a rendermi Veggente… E’ falso dire: Io penso, si dovrebbe dire: mi si pensa. Scusi il gioco di parole: IO è un altro.
VIII
Il teatro di Carmelo Bene e l’annientamento del concetto di soggetto
Carmelo Bene nato a Campi Salentina il 1 settembre del 1937 e morto il 16 marzo del 2002 a Roma per tutta la sua esistenza terrena si dedica al teatro divenendo egli stesso il teatro, come dichiara lui: Io stesso sono il teatro, come posso parlare del teatro?
Ricordate: Io è un altro!
Distruggendo il concetto di attore, come caricatura …. e re – citare, inteso come (citare la cosa), la rappresentazione teatrale diviene una non – rappresentazione, per il genio pugliese; poiché ogni rappresentazione è intesa come rappresentazione del potere dello Stato.
Carmelo dichiara: Tutta l’arte è statale.
Carmelo Bene rifiuta e distrugge il concetto stesso di soggetto e testo teatrale, fino al disfacimento della rappresentazione stessa, nel suo unicum Essere. Carmelo dichiara: Non ho poteri, non sono dalla parte del potere, non rappresento nulla se non il Nulla.
Egli diviene quello che E’, ossia: la Macchina Attoriale, e non l’attore che recita, rappresenta, che serve il potere, che ha fini consolatori o pedagogici.
C.B. distruggendo il teatro di testo e prediligendo la scrittura di scena: un teatro del dire e non del detto, rappresenta l’irrappresentabile; ciò a cui non si può dare voce e narrazione: approdando nel limbo dell’indicibile. Del Nosferatu. Del per sempre Eterno. Mai nato e quindi mai morto.
Dichiarando di non esistere. Di trovarsi innanzi ad una platea di morti.
Egli stesso dichiara che: Dopo essere stati a teatro, non potrete raccontare ciò che avete visto.
Carmelo oltrepassando la soglia del significato approdando al significante, al suono che si perdeva nel nulla del teatro e del tetro dell’esistenza, le sue performance teatrali erano mirate al dissolvendo l’Io, al deporre la volontà, al dissolvimento dell’autoaffermazione dell’io, – un teatro di addormentati -, come dichiarava lui, paragonando il teatro agli assist di Maradona, di cui non poteva essere autore, poiché, non premeditato ma immerso nell’attimo e nello smemoramento di se stesso. – Oblio dell’io – .
Tutta la sua rappresentazione, – o meglio non più sua rappresentazione – mirava al superamento di se stesso, all’inorganico. Al non esserci più, superando, abbandonandosi ad una verticalità teologica lasciando scivolare via ogni ontologia heideggeriana ridotta all’esserci, ossia all’ente. Alla presenza.
Carmelo Bene non c’era sul palcoscenico.
Carmelo Bene non esiste. Non è mai esistito.
Se abbiamo avuto l’illusione che fosse presente, ebbene, questa era semplicemente una parvenza.
Egli rappresentava l’irrappresentabile: l’Impossibile.
Carmelo Bene non rappresentava il personaggio ma il suo dissolvimento, attraverso l’abbandono della volontà soggettiva per l’abbandono nella Volontà di potenza nitzscheana; come energia e fonte irrazionale, sfrenata e indefinibile senza identità e disfacimento del concetto stesso di soggetto, forma e formalità e distruzione di ogni maschera sociale, – deve essere riconosciuta per quella che E’; ossia lungi dall’essere mal interpretata come dominio, sopraffazione e autoaffermazione dell’io, ma l’esatta antitesi, di ogni identità.
Vento che soffia dissennato e smemorato; fonte vitale senza principio, né fine.
La Volontà di potenza non è un dover – essere in divenire; è la cosa in sé, è quello che è.
L’io è in divenire. È divenuto altro da se stesso, subendo un processo di alienazione che è violenza storica – sociale di identità presa in prestito, imposta e sovrapposta a qualcosa che non si può definire, che non si può dire, che non si può comprendere ma soltanto essere compresi.
Non è un porsi di fronte a qualcosa ma essere un tutt’uno.
Non essere più.
Come in Un Amleto di meno, (da Shakespeare a Laforgue), che fa di Carmelo Bene un capolavoro, e non un capolavoro di Carmelo Bene, – dato che non si può essere autori -, il genio, mentre dissolve la trama e il personaggio di Amleto perché il suo teatro faceva a pezzi il concetto di soggetto come categoria del pensiero e dell’azione; un’operazione che consiste nel tagliare il cordone ombelicale con la tradizione teatrale della rappresentazione con la rappresentazione ormai divenuta rappresentazione del potere di Stato. Tutta l’arte era statale prima del genio di Otranto. Disarticolando la grammatica simbolica del teatro, dalla parodia del grande attore alla scoperta della phoné, fino all’inorganicità della macchina attoriale.
Diveniamo quello che siamo. La volontà di potenza non può essere divenuta.
Essa è la cosa in sé.
Non il Super – uomo (traduzione errata della parola tedesca in italiano che ha creato fin troppi fraintendimenti, fortunatamente delucidati dalla storia della filosofia) ma Oltre – Uomo; un superamento dell’uomo, non un suo rafforzamento.
Arthur Rimbaud e Carmelo Bene, abbandonando il delirio antropocentrico ed egocentrico di proclamarsi indegnamente autori, smettendo i panni del vecchio e menzognero io sono: che dipana la menzogna di essere e di sapere; abbandonando ogni volontà di e vanità, possono semplicemente definirsi – o meglio non definirsi, poiché dimessa la volontà dell’io – proclamarsi Capolavori.
IX
L’annientamento del concetto dell’Io in due poeti della nostra Puglia Angiuli e Zizzi
La prossima volta voglio rinascere ulivo, dichiara il poeta Lino Angiuli, classe 1946, nato a Valenzano ma residente da tantissimi anni a Monopoli.
La concezione di Lino sull’ego è quella orientale: un’immagine illusoria che si identifica con la coscienza di soggetto; un pericolo da abbattere.
La coscienza per me è il velo dei Maya. Noi dobbiamo continuamente abbattere; è una scommessa di carattere sensoriale; un superamento continuo di se stessi, quello di viaggiare per la conoscenza. L’identificazione con altro da sé è un passo avanti verso la fuoriuscita dalla menzogna novecentesca, perché la Storia del Novecento ci offre un ego ipertrofico e conflittuale. Lino Angiuli prediligendo le filosofie orientali crede, come Gozzano, nel suo misticismo afferma che: il poeta sia un grumo di sogni.
La nostra Puglia, oltre all’amico Lino Angiuli ha il martinese Michelangelo Zizzi incluso nel Dizionario critico della poesia italiana 1945 – 2020 a cura di Mario Fresa.
Con il suo ultimo poema La Resistenza dell’impero in cui egli stesso dichiara: questa è la mia autobiografia né addizionale né minimale, in cui c’è inevitabilmente troppo io, anche se il compito più alto di ogni poesia è la morte dell’io. Zizzi s’identifica con un monaco savio, che, aggirandosi nelle prigioni della modernità, cerca di fare resistenza con l’identità – impero ma non con l’io.
Nella poesia di Zizzi l’io è il luogo riservato alla menzogna, per quanto pubblico esso sia; attraverso il linguaggio si rende pubblico l’io che diviene manifesto della sua impostura. Eccedere e scavalcare l’io è una dinamica che ci ricongiunge col divino -, una strada del ritorno dell’impostura della storia umana, con l’ontologia; proprio come il viaggio psicopompo dantesco di cui poc’anzi scritto. L’approdo della morte dell’io è l’identificazione col divino, attraverso il fuoco sacro della poesia scavalca il linguaggio attraverso la sua potenza evocativa.
Epilogo di un notturno prima d’alba
È il buio prima dell’alba. Un momento magico. Né notte e non ancora mattino.
I primi bagliori asciugano le lacrime della notte scorsa.
Sento dentro di me perire qualcosa – annegare nell’alba sull’orizzonte dell’Adriatico tutta la tempesta dell’io in subbuglio della notte autunnale appena trascorsa.
Deliro l’infinito Adriatico – onda dopo onda fino a forare l’orizzonte – , cerco di comprendere questa emozione ma il pensiero ha già forato l’orizzonte dei mari, e che porti leccornie per i buoni poeti.
Ma adesso il regno del sonno stanzia il suo impero distruggendo l’io.
Tutto questo è la resa del linguaggio che non sa dire e del pensiero che non può comprendere, poiché compreso.
E tutti i libri rimangono immersi negli occhi per sempre deliranti dell’Adriatico.
Fabio Angiulli